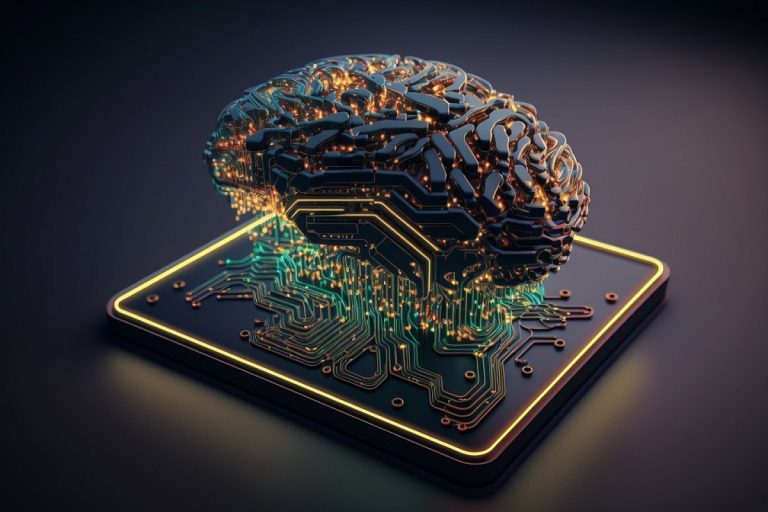L’Italia è un caso unico in Europa: secondo il rapporto Ember, quest’anno è riuscita a ridurre l’impatto del gas e del carbone sul prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica al 19% delle ore, rispetto al 75% del 2019. Grazie a ciò, il prezzo medio all’ingrosso in Italia è stato inferiore del 32% rispetto alla media europea. Tuttavia, qualcosa non quadra: il consumatore continua a pagare bollette elevate. Perché il prezzo non scende?
Il paradosso energetico dell’Italia: perché l’energia verde non rende l’elettricità più economica

Analizziamo la situazione in ordine cronologico. Dal 2019, l’Italia ha aggiunto oltre 40 GW di nuova potenza solare ed eolica, raddoppiando le sue fonti di energia rinnovabile. Nella prima metà di quest’anno, il 46% dell’elettricità generata era pulita. Ma il 28 aprile 2025 è arrivata una doccia fredda: un grande blackout. Una serie di guasti elettrici e la mancanza di riserve operative hanno lasciato gran parte del Paese senza elettricità per diverse ore.
Il rapporto preliminare dell’ENTSO-E ha escluso che l’energia rinnovabile fosse la causa diretta, ma ha evidenziato un problema strutturale: la rete italiana non era pronta per una generazione così intermittente senza una sufficiente flessibilità. Da allora, Terna (l’operatore di sistema italiano) gestisce il sistema in “modalità rafforzata”, utilizzando più attivamente gli impianti a ciclo combinato per stabilizzare la tensione. Secondo Ember, questa strategia è stata costosa: a maggio, i servizi di rete basati sul gas hanno rappresentato il 57% del prezzo finale dell’energia elettrica, contro il 14% prima del blackout.
Il problema chiave. L’Italia produce più energia elettrica pulita che mai, ma non è in grado di sfruttarla appieno. La carenza di reti, accumulatori e interconnessioni fa sì che migliaia di megawatt di energia solare ed eolica rimangano inutilizzati. Sebbene sia in corso un piano per rafforzare queste interconnessioni, che rappresentano un collo di bottiglia, la realtà è che quando si verifica un eccesso di energia pulita e non è possibile esportarla, questa viene “scartata” . Secondo Ember, la perdita di generazione (energia rinnovabile persa) è triplicata dopo il blackout, passando dall’1,8% al 7,2%.
Inoltre, il Paese è ancora in ritardo in termini di flessibilità. Per quanto riguarda gli investimenti nelle batterie, l’Italia è in ritardo: è al quarto posto nel mercato energetico europeo, ma solo al tredicesimo posto per quanto riguarda le batterie, con soli 120 MW installati. Nonostante i piani per raggiungere i 16.000 MW entro il 2030.
La causa di questi problemi è strutturale e può essere compresa se si considera che gli investimenti nella rete ammontano a soli 30 centesimi per ogni euro destinato alle energie rinnovabili, ovvero la metà della media europea. In altre parole, abbiamo più sole che cavi.
Il costo della paura. Il problema non è solo tecnico, ma anche economico. Come ha osservato l’analista Alessandro Rossino, il funzionamento in regime di emergenza da aprile è costato ai consumatori un miliardo di euro in più. E questo è solo l’inizio: l’approvazione del nuovo regime di emergenza potrebbe aggiungere altri 3 miliardi di euro e aprire la porta ad un aumento delle tariffe fisse da parte dei distributori.
Il costo di mantenere la rete “in tensione” si ripercuote direttamente sulle bollette, anche se il prezzo all’ingrosso è basso. Lo stesso rapporto Ember sottolinea che il prezzo del mercato all’ingrosso copre solo circa la metà della bolletta elettrica, la cosiddetta “componente energetica”. Il resto – reti, tasse, imposte, stabilità del sistema – non diminuisce, anche se l’energia elettrica alla fonte diventa più economica. Di conseguenza, il calo dei prezzi all’ingrosso non porta automaticamente a una riduzione delle bollette.
Ancora una volta lo spettro del blackout. Ci sono voluti solo sei mesi perché si verificasse un nuovo pericoloso guasto. Terna ha segnalato “forti oscillazioni di tensione” nel sistema, così gravi da richiedere l’autorizzazione urgente dell’ARERA per modificare alcune procedure operative. Tra le misure: maggiore margine di manovra prima dell’inizio della giornata operativa e controllo più rigoroso della tensione reattiva. Rapido adeguamento del funzionamento del sistema energetico nazionale per contenere le variazioni di tensione.
La stessa Terna ha insistito sul fatto che “non c’è un rischio inevitabile di blackout”, ma la verità è che nessuno si sente tranquillo. Ogni giorno di lavoro in queste condizioni aggiunge costi che alla fine ricadono sui clienti. Lo spettro del blackout è ancora presente: meno visibile, ma più costoso.
Da soluzioni temporanee a flessibilità pura. Dopo il blackout è stato approvato un pacchetto di riforme con misure volte a rafforzare la rete e incentivare l’accumulo di energia. Sebbene il decreto sia stato respinto dal Parlamento, molte delle sue disposizioni vengono attuate in altri modi. Tra questi spiccano l’installazione di otto compensatori sincroni – dispositivi che stabilizzano la tensione senza utilizzare combustibili fossili – e un portafoglio di progetti di accumulatori da 2600 MW, di cui 340 MW già autorizzati.
Ember ha calcolato che i compensatori richiederanno un investimento di 750 milioni di euro, ma consentiranno di risparmiare 200 milioni di euro all’anno grazie alla riduzione dell’uso di gas per i servizi di rete. L’obiettivo è chiaro: passare dal gas come stampella alla flessibilità pulita come base del sistema.
Il paradosso dell’Italia. L’Italia è il laboratorio energetico europeo: il Paese in cui le energie rinnovabili hanno dimostrato di poter ridurre il prezzo all’ingrosso, ma anche quello in cui è più evidente quanto sia costoso sostenere questa transizione senza reti affidabili. Come spiegato nel rapporto Ember, circa il 50% della bolletta elettrica in Italia corrisponde alla componente energetica, che è effettivamente diminuita. Il resto sono costi di sistema e quindi, anche se il megawattora costa meno, la bolletta finale non diminuisce.
Una sfida enorme. L’Italia ha dimostrato di poter avere l’energia elettrica più economica d’Europa e allo stesso tempo una delle bollette più alte.
Perché la transizione energetica non si misura solo in megawatt o pannelli solari, ma anche in cavi, stabilità e fiducia. Il compito ora non è quello di produrre più energia pulita, ma di distribuirla – e pagarla – in modo equo.